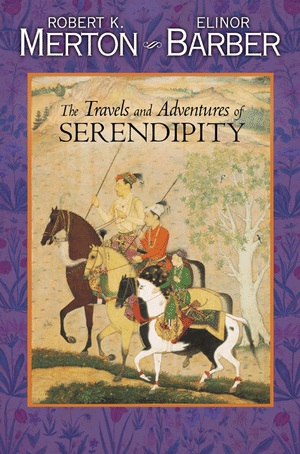mercoledì 30 maggio 2012
L'introduzione del focus group in sociologia
Un po' di storia. Come ricorda anche Mario Cardano all'inizio del capitolo 5, la diffusione della tecnica del focus group in sociologia deve molto al lavoro metodologico di Robert K. Merton che la introduce tra i metodi della nostra disciplina con un libro scritto con Marjorie Fiske e Patricia L. Kendall dal titolo The Focused Interview. A Manual of Problems and Procedures (The Free Press, New York) uscito negli USA nel 1956. L'introduzione della nuova tecnica viene sottolineata nella introduzione alla seconda edizione (pubblicata nel 1990), a firma di Merton, e poi viene diffusamente trattata nel capitolo VII "The Group Interview". La tecnica, però, ha avuto un'ampia diffusione in discipline affini alla sociologia: ad esempio negli studi valutativi, nel marketing, nella scienza politica, oltre agli studi sull'opinione pubblica che erano al centro degli interessi di Merton, quando scriveva il volume metodologico del 1956.
martedì 29 maggio 2012
Esperienze di analisi di interviste
Per approfondire. L'attività pratica di trascrizione di un'intervista audio-video vi ha consentito di fare esperienza delle problematiche di ordine pragmatico e interpretativo che sono implicate in tale attività. Anche nei manuali di metodologia e tecnica della ricerca sociale non viene prestata molta attenzione a queste fasi di ricerca che vengono ritenute meno problematiche o poco importanti in termini metodologici. L'esperienza, invece, dimostra il contrario e dà la misura delle distorsioni che possono generarsi e, quindi, degli opportuni accorgimenti e delle riflessioni di metodo che sono necessarie per gestire in maniera consapevole tali attività. Vi suggerisco una lettura di approfondimento che permettere di comprendere queste tematiche con riferimento diretto ad alcune esperienze: si tratta del libro di Felice Addeo e Paolo Montesperelli, Esperienze di analisi di interviste non direttive (Aracne, Roma, 2007), la cui bibliografia suggerisce ulteriori letture e spunti per altri approfondimenti.
Etichette:
bibliografia,
interviste,
libri,
trascrizione
mercoledì 16 maggio 2012
Serendipity
Maria Luisa Maniscalco, "Serendipity in the Work of Robert K. Merton", in Mongardini C, Tabboni S. (eds.), Robert K. Merton & Contemporary Sociology, Transaction Publishers, New Jersey, 1998, pp. 273-284.
lunedì 23 aprile 2012
Per andare dove dobbiamo andare, da che parte dobbiamo andare?
Esercitazione in corso (o quasi). In un famoso film commedia del 1956 dal titolo "Totò, Peppino e... la malafemmina", in un famoso sketch il grande Totò chiede informazioni al vigile milanese e, tra le altre cose, in una formula esilarante domanda: "per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?". Io oggi mi trovo nella situazione del vigile a Milano e voi in quella di Totò e Peppino, visto che per la nostra esercitazione non è stato ancora redatto un primo disegno della ricerca. Non sappiamo "dove dobbiamo andare" che rappresenta il fine della nostra attività strategica di ricerca, condensato nelle domande di ricerca; e non sappiamo ancora "per dove dobbiamo andare" che rappresenta l'insieme delle scelte di metodo da fare per rispondere in maniera appropriata alle domande di ricerca. Domani qualcuno saprà rispondere alla mia domanda: per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?
giovedì 19 aprile 2012
Filmografia citata
Rappresentare. Oggi in aula è stato richiamato il regista Ken Loach e alcuni suo lavori cinematografici come esempi di come una storia può svolgere la funzione illustrativa di rappresentare un fenomeno sociale. Poiché - se ho capito bene - nessuno ne ha mai sentito parlare, vi segnalo i filma richiamati: In questo mondo libero (2007) sul caporalato al femminile tra gli immigrati dell'Est in Inghilterra; Paul, Mick e gli altri (2001) sui disoccupati di Sheffield; Bread and Roses (2000) sui clandestini messicani che passano il confine in California per lavorare in America; Piovono pietre (1993) sugli operai disoccupati di Manchester durante il periodo del neoliberismo thatcheriano; Riff Raff. Meglio perderli che trovarli (1991) sulla vita quotidiana che riflette gli effetti della politica della Thatcher.
Etichette:
cinema,
esempi,
Ken Loach,
rappresentazione
martedì 17 aprile 2012
Ricerca bibliografica
Qualche risorsa. Nell'ambito dell'attività di esercitazione ci siamo impegnati a realizzare una ricerca bibliografica al fine di: (a) definire una domanda di ricerca; (b) qualificare la rilevanza teorica (e pragmatica) della nostra domanda di ricerca. Come spiegato in aula oggi si tratta di un'attività strumentale alla definizione di un quadro teorico-concettuale entro il quale definire la rilevanza della domanda di ricerca e seguire tutte le altre fasi della prefigurazione nell'ambito della elaborazione del disegno della ricerca.
Vi segnalo qualche strumento per la ricerca bibliografica. In primo luogo gli strumenti per selezionare teorie, concetti e definizioni:
Vi segnalo qualche strumento per la ricerca bibliografica. In primo luogo gli strumenti per selezionare teorie, concetti e definizioni:
- i dizionari disciplinari (ad esempio il Dizionario di Sociologia di Luciano Gallino);
- i thesaurus, con cui ricostruire le parole-chiave - keywords - secondo alberi gerarchici (ad esempio Thematic List of Descriptors : Sociology, dell'UNESCO; oppure Thesaurus of sociological indexing terms, di Bárbara Booth);
- manuali di settore (ad esempio per il vostro caso: Handbook of Sports Studies, di Jay J. Coakley, Eric Dunnin).
- riviste scientifiche specialiste di settore (ad esempio per il vostro caso: International Review for the Sociology of Sport).
- Cominciamo dalle risorse UniNa: il Centro d'Ateneo per le Biblioteche (CAB) per indicazioni bibliografiche e per accesso alle risorse elettroniche online.
- Archivi digitali di riviste scientifiche (full text): Jstor oppure Web of Knowledge (risorse che richiedono l'identificazione dell'utente e dell'istituzione);
- Archivio digitale di articoli (full text) lingua francese: Persée.
- Archivio libri digitali: Darwinbooks (il Mulino).
- La pubblicazione periodica Sociological Abstracts (digitale e cartaceo, consultabile presso la biblioteca di Facoltà);
- L'archivio online Biblioteca della Sociologia Italiana on line dell'Università degli Studi di Trento (Facoltà di Sociologia, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale) ad accesso libero.
Il disegno della ricerca qualitativa
In secondo luogo abbiamo focalizzato l'attenzione sull'attività di prefigurazione, a monte di una ricerca, di quella di ricostuzione, a valle di un percorso di ricerca, e quella circolare che riguarda durante lo svolgimento della ricerca il rapporto tra processi interpretativi, scelte metodologiche e dati empirici. Abbiamo, poi, riconsiderato queste fasi all'interno della teoria dell'argomentazione, considerando in dettaglio il significato di argomentazione prolettica.
A questo punto, abbiamo visto una parte delle attività che riguardano la prefigurazione, in particolare:
- la specificazione della domanda di ricerca e la qualificazione della sua rilevanza (pragmatica/teorica);
- l'individuazione del contesto empirico che consente di rispondere alla domanda di ricerca e di trovare gli elementi per argomentare l'appropriatezza della risposta (setting e case);
- la descrizione del metodo impiegato per elaborare una risposta alla domanda di ricerca.
mercoledì 11 aprile 2012
La ricerca biografica in sociologia
Si cambia vita. Ci siamo messi alle spalle con la lezione di oggi il testo della Ruspini con un'ultima riflessione sulla ricerca a fondamento biografico. Abbiamo visto come questo approccio di ricerca ai accede alle connessioni tra le singole biografie e la storia sociale, tra la dimensione strettamente individuale e il contesto sociale. Le forme della ricerca biografica che abbiamo discusso con più attenzione sono state sostanzialmente tre:
a) l'analisi delle storie di vita;
b) lo studio del corso di vita;
c) lo studio degli eventi e delle transizioni di vita.
Le storie di vita o biografie sono l'insieme cronologico narrativo relativo alla vita di un soggetto; mentre il corso di vita fa riferimento alla struttura sottostante alle biografie, socialmente costruita, articolata in fasi che si susseguono lungo traiettorie che riguardano aspetti specifici della vita di un soggetto; le fasi sono separate da eventi che definiscono transizioni di rilevanza sociale da uno stato e il successivo lungo una traiettoria biografica.
La ricerca biografica in sociologia ha ormai assunto un livello di autonomia da rappresentare un filone di ricerca autonomo, a prescindere dai metodi di ricerca utilizzati. Una breve lettura di approfondimento è il libricino di Manuela Olagnero e Chiara Saraceno "Che vita è: l'uso dei materiali biografici nell'analisi sociologica" (La Nuova Italia Scientifica, 1993). Le stesse autrici hanno scritto sull'approccio biografico in molti altri volumi di cui segnalo a chi fosse particolarmente motivato a documentarsi due volumi: (1) Manuela Olagnero, "Vite nel tempo" (Carocci, 2005); (2) Chiara Saraceno, a cura di, "Età e corso della vita" (il Mulino, 2001).
a) l'analisi delle storie di vita;
b) lo studio del corso di vita;
c) lo studio degli eventi e delle transizioni di vita.
Le storie di vita o biografie sono l'insieme cronologico narrativo relativo alla vita di un soggetto; mentre il corso di vita fa riferimento alla struttura sottostante alle biografie, socialmente costruita, articolata in fasi che si susseguono lungo traiettorie che riguardano aspetti specifici della vita di un soggetto; le fasi sono separate da eventi che definiscono transizioni di rilevanza sociale da uno stato e il successivo lungo una traiettoria biografica.
La ricerca biografica in sociologia ha ormai assunto un livello di autonomia da rappresentare un filone di ricerca autonomo, a prescindere dai metodi di ricerca utilizzati. Una breve lettura di approfondimento è il libricino di Manuela Olagnero e Chiara Saraceno "Che vita è: l'uso dei materiali biografici nell'analisi sociologica" (La Nuova Italia Scientifica, 1993). Le stesse autrici hanno scritto sull'approccio biografico in molti altri volumi di cui segnalo a chi fosse particolarmente motivato a documentarsi due volumi: (1) Manuela Olagnero, "Vite nel tempo" (Carocci, 2005); (2) Chiara Saraceno, a cura di, "Età e corso della vita" (il Mulino, 2001).
Iscriviti a:
Post (Atom)